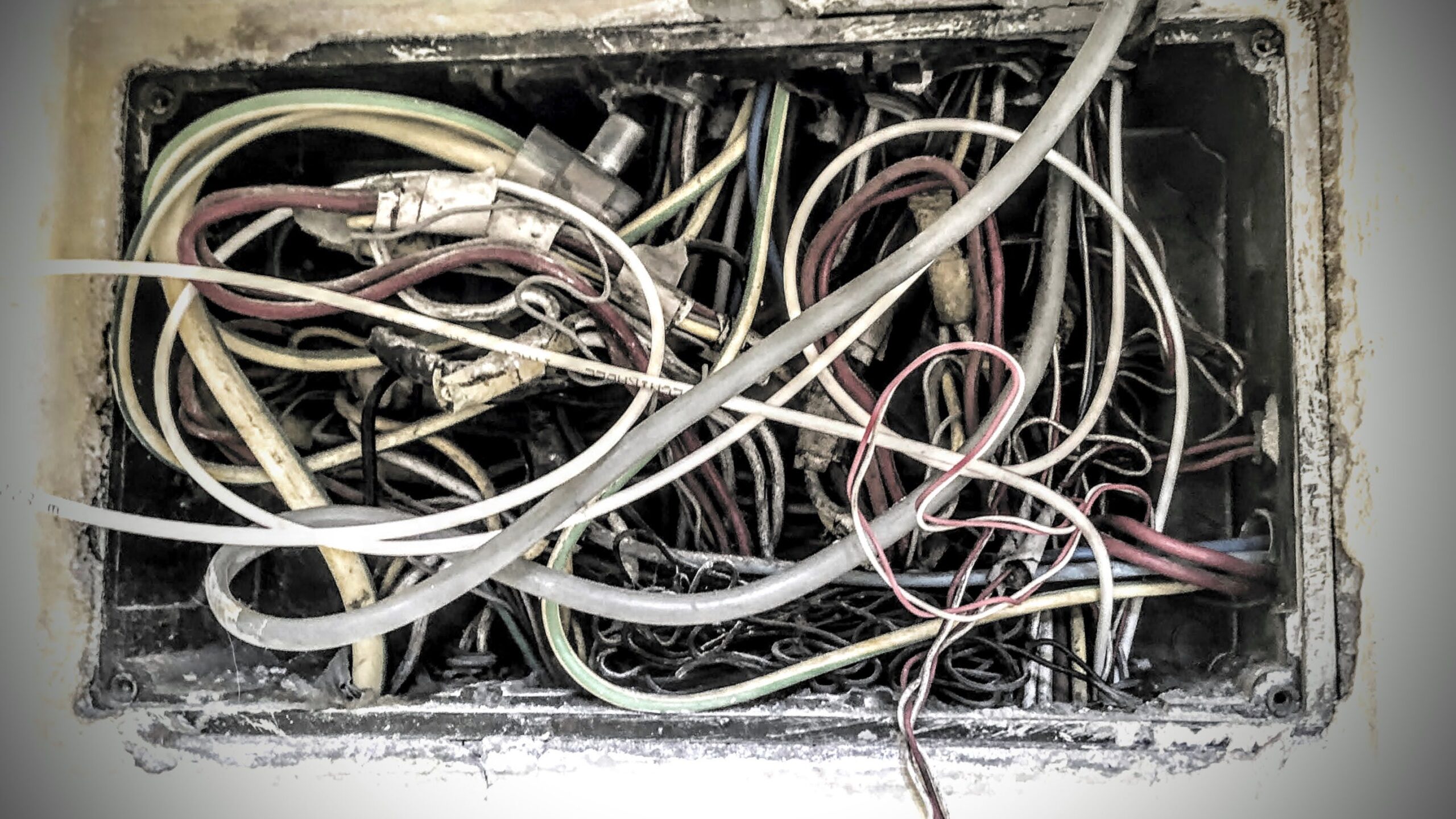È estate: rinfreschiamo la mente con un giochino logico. Calcoliamo la negazione della frase: “A tutti noi piace il caffè e a Paola non piace il caffè”.
Cominciamo introducendo qualche abbreviazione.
- La prima è la singola e semplice lettera x. La useremo per indicare una persona generica. Mentre “Paola è una persona” è un’affermazione specifica e ben determinata “x è una persona” è generica e, prima di poter dire se sia vera o falsa, è necessario rimpiazzare x con specifici valori, come per esempio Paola. Possiamo indicare la frase generica con un’etichetta e l’aggiunta dell’indicazione che x è una variabile, qualcosa che si può sostituire con valori specifici. Per esempio, se scegliamo la lettera P come etichetta della frase di sopra, con la notazione P(x) vogliamo indicare che la frase è generica e che ad x va sostituito un valore specifico per poter valutare se sia vera o falsa. P(x/Paola) significa: deriva da P(x) una frase ottenuta sostituendo ad x il valore Paola.
- Sia T l’insieme di tutti noi esclusa Paola. T è un insieme di persone, quindi x può essere usato anche per indicare uno dei suoi elementi.
- Con la A maiuscola rovesciata indichiamo l’espressione: “per ogni” (in inglese: for All). Dunque il costrutto ∀x∈T si può leggere come l’inizio di una frase: “per ogni valore che x può via via assumere in T…”.
- Con la E maiuscola rovesciata, indichiamo l’espressione: “per qualche” (in inglese Exists). Il costrutto ∃x∈T si legge: “per qualcuno dei valori che x può assumere in T…”.
- “∧”, “∨”, e “¬” indicano rispettivamente: la congiunzione logica (es. “oggi c’è sole e sto andando al mare”), la disgiunzione logica inclusiva (es. “oggi piove leggermente o c’è un po’ di vento”, la quale sottintende che oggi ci possono essere contemporaneamente la pioggia leggera ed il vento, oppure solo uno dei due fenomeni ma di sicuro almeno uno), la negazione (es. “oggi non piove”).
Facciamo qualche esempio.
- Abbreviamo con K(x) la frase: “a x piace il caffè”.
- A questo punto:
- ∀x∈T K(x) significa: “per ogni x di T, a x piace il caffè”, cioè: “a ognuno di noi escldendo Paola, piace il caffè”;
- ∃x∈T ¬K(x) significa: “esiste un x tale che a x non piace il caffè”, cioè “a qualcuno di noi escludendo Paola, non piace il caffè”;
- K(Giovanni) ∧ K(Paola) significa: “a Giovanni piace il caffè e a Paola piace il caffè” o, meglio: “a Giovanni e a Paola piace il caffè”;
- ¬¬K(Paola) si legge (notate la doppia negazione): “non è vero che a Paola non piace il caffè” che, si può semplificare in: “a Paola piace il caffè”, cioè K(Paola).
Ora vediamo un caso più complicato: ¬∀x∈T K(x), che si legge: “non per ogni x di T, a x piace il caffè”, cioè “non ad ognuno di noi, senza considerare Paola, piace il caffè”. Affinché ciò sia vero, è sufficiente che ad almeno uno di noi, senza considerare Paola, piaccia il caffè, la qual cosa si abbrevia in: ∃x∈T ¬K(x).
Proviamo a ridire lo stesso concetto in un altro modo. ∀x∈T K(x) è come una congiunzione tra tutte le proposizioni ottenute sostituendo a x in K(x) ad uno ad uno i valori che si trovano in T. Supponiamo per esempio che T sia l’insieme costituito da queste persone: {Arnaldo, Biancarosa, Cieleste, Donatello, Eugenia}. Allora, ∀x∈T K(x) è l’abbreviazione di: K(Arnaldo) ∧ K(Biancarosa) ∧ K(Cieleste) ∧ K(Donatello) ∧ K(Eugenia). Dunque:
- ¬∀x∈T K(x) è vera se, e solo se, ∀x∈T K(x) è falsa.
- ∀x∈T K(x) è falsa se, e solo se, K(Arnaldo) ∧ K(Biancarosa) ∧ K(Cieleste) ∧ K(Donatello) ∧ K(Eugenia) è falsa.
- Affinché K(Arnaldo) ∧ K(Biancarosa) ∧ K(Cieleste) ∧ K(Donatello) ∧ K(Eugenia) sia falsa, è sufficiente che almeno una tra K(Arnaldo), K(Biancarosa), K(Cieleste), K(Donatello) e K(Eugenia) sia falsa.
- Almeno una tra K(Arnaldo), K(Biancarosa), K(Cieleste), K(Donatello) e K(Eugenia) è falsa se, e solo se, almeno una tra le negazioni di tali affermazioni è vera, cioè se, e solo se, almeno una tra: ¬K(Arnaldo), ¬K(Biancarosa), ¬K(Cieleste), ¬K(Donatello) e ¬K(Eugenia) è vera.
- In altri termini, almeno una tra ¬K(Arnaldo), ¬K(Biancarosa), ¬K(Cieleste), ¬K(Donatello) e ¬K(Eugenia) è vera se, e solo se, la disgiunzione inclusiva tra tali affermazioni è vera cioè se, e solo se, ¬K(Arnaldo) ∨ ¬K(Biancarosa) ∨ ¬K(Cieleste) ∨ ¬K(Donatello) ∨ ¬K(Eugenia) è vera.
- ¬K(Arnaldo) ∨ ¬K(Biancarosa) ∨ ¬K(Cieleste) ∨ ¬K(Donatello) ∨ ¬K(Eugenia) è vera se, e solo se, ad almeno uno di noi, senza considerare Paola, non piace il caffè.
- In altri termini, ¬K(Arnaldo) ∨ ¬K(Biancarosa) ∨ ¬K(Cieleste) ∨ ¬K(Donatello) ∨ ¬K(Eugenia) vale se, e solo se, esiste almeno un x di T tale per cui valga ¬K(x).
- Questo si abbrevia con: ∃x∈T ¬K(x).
Abbiamo quindi scoperto che ¬∀x∈T K(x) equivale a ∃x∈T ¬K(x).
Ci siamo! Possiamo completare il compito iniziale, cioè calcolare la negazione della frase: “A tutti noi piace il caffè e a Paola non piace il caffè”.
- Cominciamo con l’osservare che la frase è la congiunzione di due frasi:
- A tutti noi piace il caffè;
- A Paola non piace il caffè.
- Nel linguaggio naturale, contesto e buon senso sono utilizzati ad ogni piè sospinto per snellire la comunicazione. In questo caso, nella prima fase va esplicitato un sottinteso: Paola non è considerata. Diversamente, si potrebbe dare un caso assurdo, in cui si dichiara che a Paola piace il caffè, in quanto è una di noi e a tutti noi piace il caffè, e a Paola non piace il caffè per esplicita indicazione. Impensabile che valga al contempo un’affermazione e la sua negazione! Follia!!! In conclusione, la prima frase va meglio esplicitata con: “a tutti noi piace il caffè, senza considerare Paola”.
- Abbiamo già incontrato queste due frasi, o frasi simili, e sappiamo già come abbreviarle. Esse diventano, nell’ordine:
- ∀x∈T K(x)
- ¬K(Paola)
- La loro congiunzione è quindi: (∀x∈T K(x))∧(¬K(Paola))
- La negazione di questa affermazione composta è, in simboli formali: ¬((∀x∈T K(x))∧(¬K(Paola)))
- In generale, se A e B sono affermazioni, è facile comprendere che la negazione della loro congiunzione è la disgiunzione debole delle loro negazioni. In simboli è più leggibile: ¬(A∧B) =(¬A)∨(¬B). In altri termini, “è falso che A e B valgano contemporaneamente” equivale a dire che “almeno una tra ¬A e ¬B è vera”, cioè “o ¬A è vera, o ¬B è vera o lo sono entrambe contemporaneamente”.
- Nello specifico, ¬((∀x∈T K(x))∧(¬K(Paola))) equivale a (¬∀x∈T K(x))∨¬(¬K(Paola)).
- In generale, la negazione della negazione è vera se e solo se è vera l’affermazione di partenza: ¬(¬A) = A. Nello specifico, ¬(¬K(Paola)) equivale a K(Paola). Dunque possiamo semplificare la scrittura precedente in: (¬∀x∈T K(x))∨K(Paola).
- Ricordiamo il lavoro fatto precedentemente per passare, in generale, dalla negazione di un costrutto che inizia con ∀ ad un costrutto logicamente equivalente che inizia con ∃ prosegue con la negazione dell’affermazione generica iniziale. Nel caso specifico, ¬∀x∈T K(x) equivale a ∃x∈T ¬K(x). Possiamo quindi sostituire il primo costrutto usando il secondo nella nostra formulona, che diventa: (∃x∈T ¬K(x))∨K(Paola).
- “Sfogliando” le abbreviazioni, questa si legge: “o esiste almeno un x che sta in T a cui non piace il caffè o a Paola piace il caffè o sono vere entrambe le cose contemporaneamente”. Più discorsivamente: “o a qualcuno di noi, senza considerare Paola, non piace il caffè, o a Paola piace il caffè oppure valgono entrambe le cose contemporaneamente“.

Fotografie di Nicola Granà