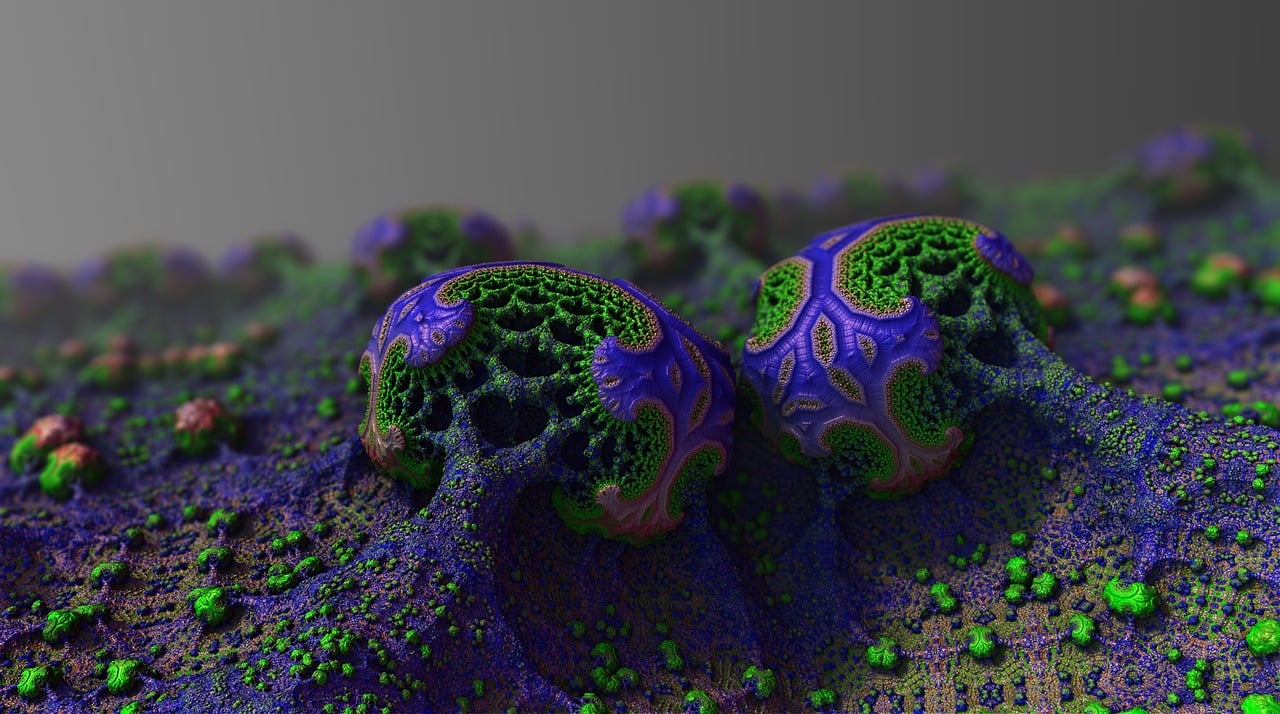Cos’è il paradigma della complessità? Da dove cominciare per studiarlo? Cosa leggere, quali video guardare? Con chi confrontarsi? A cosa serve? Come utilizzarlo nel lavoro, in famiglia, in comunità, in società? Che rapporto c’è con l’approccio olistico?
Cos’è il paradigma della complessità?
Un paradigma del pensiero scientifico è costituito da regole metodologiche, modelli esplicativi, criteri di soluzione di problemi. Una rivoluzione scientifica è un cambio di paradigma. Le nuove mentalità o paradigmi cognitivi sono indotte dalle rivoluzioni scientifiche, si pensi alla teoria della relatività e al relativismo.
L’ultimo paradigma è quello della complessità.
Il paradigma della complessità, come l’approccio olistico, rifiuta l’idea semplicistica secondo la quale un sistema si spiega come semplice somma delle parti. Gli intrecci tra le parti del sistema rendono il tutto superiore alla somma delle parti. La vita, per esempio, non si può spiegare come semplice composto chimico ma è organizzazione, è uno schema che tende a conservarsi e replicarsi.
In più, rispetto all’approccio olistico, il paradigma della complessità fa entrare in gioco il rapporto tra osservatore ed osservato, ammettendo la possibilità di modellare anche quando il controllo dell’osservatore non è completo. Un sistema in cui le parti interagiscono tra loro può essere complicato ma, finché l’osservatore ritiene di averne il controllo completo, non varca la soglia della complessità.
Materiali per iniziare comprendere il paradigma della complessità

Pagine Web da leggere
- “L’ordito e la trama” del prof. Giuseppe Zollo
- La pagina di Wikipedia sull’Epistemologia della Complessità
Dipinti
Di fronte a molte delle opere di Pollock o Kandisky, il cervello non è in grado di riconoscere caratteristiche pre-codificate: non focalizza l’oggetto.


Video
- Trama, Abbraccio – La mente innamorata del Complexity Institute, con prof. Giuseppe Zollo
Libri
- Auto-organizzazioni di Alberto F. De Toni, Luca Comello, Lorenzo Ioan
- Nexus di Mark Buchanan
- Visual Complexity di Manuel Lima
- Ciclo di Dune, saga fantascientifica di Frank Herbert: Dune (1965), Messia di Dune (1969), I figli di Dune (1977), L’imperatore-dio di Dune (1981), Gli eretici di Dune (1984), La rifondazione di Dune (1985)


Siti Web da seguire
Immagine di copertina: Foto di Pete Linforth da Pixabay